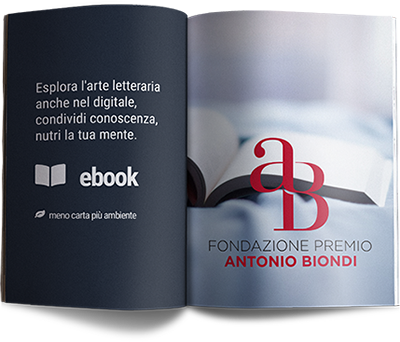EDITORIALE DELLA FONDAZIONE
I Rioni di Roma (quinta parte)
Le 22 regiones di Roma
Celio
Ed eccoci arrivati all’ultimo appuntamento con la nostra storia sui Rioni di Roma: Celio.
Lo stemma del XIX Rione Celio raffigura il profilo di un africano con un copricapo di testa di elefante,
ornato con spighe d’oro, su sfondo argento.
Il significato araldico è riconducibile alla memoria storica dei legionari capitanati dal Console
Scipione detto l’Africano, qui accampati; a ciò contribuì anche il ritrovamento archeologico nel Rione
di un busto marmoreo raffigurante un “africano” (oggi ai Musei Capitolini).
Maestoso e imponente si erge qui il Colosseo e alle sue spalle la particolarissima Chiesa della
Navicella.
Istituito nel 1921, dopo la suddivisione del Rione X Campitelli, il Rione prende il suo nome da Celio
Vibenna, il condottiero etrusco che nel VI secolo a.C., insieme al fratello Aulo, conquistò Roma e
scelse questa zona per abitarvi.
Anticamente, il Colle Celio, su cui si estende il Rione, veniva chiamato Querquetulano, perché
interamente ricoperto di querce; in età repubblicana, l’area venne costellata da lussuose ville
patrizie e assunse la vocazione di zona residenziale che ancora oggi mantiene.
Il Rione, infatti, ospita molte abitazioni private, hotel, B&B, ristoranti e locali che ne fanno un luogo
vivace ma accogliente: grazie agli ampi viali alberati e ai numerosi spazi verdi che lo caratterizzano, il
Celio è ideale per una passeggiata tra natura ed antichità, in un’atmosfera evocativa e sospesa nel
tempo.
L’Anfiteatro Flavio è la maestosa concretizzazione della grandezza di Roma che da quasi duemila anni
racconta una storia ininterrotta di fascino e magnificenza con a fianco l’Arco di Costantino, il più
grande dei tre archi trionfali ancora conservati a Roma.
Simbolo del Rione e di Roma nel mondo, il Colosseo, grandioso edificio per lo spettacolo e il
divertimento dei cittadini, costruito per essere un emblema della potenza imperiale, fu destinato ai
combattimenti, ai giochi tra i gladiatori (munera), alle simulazioni di caccia ad animali feroci ed esotici
(venationes) e alle naumachie (combattimenti navali).
Lungo 189 metri, largo 156, per un’altezza di oltre 48 metri, si estende su una superficie di 24.000
metri quadrati e poteva ospitare circa 50mila spettatori; l’arena misurava 76 metri per 46 ed i suoi
sotterranei, dove si svolgevano i preparativi per gli spettacoli, celavano una complessa macchina
scenica della morte.
Per far sì che tutto funzionasse alla perfezione, uomo e ingranaggi interagivano all’unisono: diverse
botole si aprivano per fare apparire a sorpresa combattenti e fiere che venivano sollevati da 28
montacarichi di legno e corde, mediante un articolato sistema di argani.
Possiamo poi ammirare il Museo della Forma Urbis, da poco inaugurato, che custodisce i frammenti
superstiti della celebre Forma Urbis Romae, la meravigliosa mappa marmorea che restituisce un
panorama unico del paesaggio urbano della Roma antica ai tempi di Settimio Severo, oltre al Parco
archeologico del Celio che ospita una moltitudine di reperti archeologici, architettonici ed epigrafici,
provenienti dai grandi scavi di fine Ottocento per la realizzazione di nuovi quartieri.
Altre testimonianze artistiche del luogo sono: la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, detta anche
la “Chiesa dei Lampadari” che diffondono al suo interno spettacolari effetti di luce, le Case romane
del Celio, lo straordinario complesso archeologico che racchiude oltre quattro secoli di storia e che
testimonia il passaggio e la convivenza tra paganesimo e cristianesimo, la Basilica dei Santi Quattro
Coronati, una vera e propria fortezza medievale al centro di Roma e uno dei monumenti più ricchi di
storia, arte e spiritualità della Capitale.
Meritano poi una visita: Villa Celimontana, un delizioso parco ricco di giardini ornati da sculture
antiche, fontane e aranci amari e dall’obelisco egizio di Ramses II, l’Arco di Dolabella e Silano, una
delle due sole porte che ancora si aprono nelle Mura Serviane, la Fontana della Navicella, che prende
il suo nome da un’antica galera romana di cui è la raffigurazione in miniatura, la Chiesa di Santo
Stefano Rotondo, la più antica chiesa a pianta circolare di Roma, e Porta San Sebastiano, la più grande
e meglio conservata porta incastonata nelle Mura Aureliane, al cui interno si trova l’imperdibile Museo
delle Mura e da cui si diparte la regina viarum, Via Appia Antica.
Testaccio
Il XX Rione è Testaccio: il nome deriva dal mons Testaceus, dal latino testae (cocci), perciò
soprannominato dai Romani “Monte dei Cocci”.
Il monte, infatti, non è altro che una collinetta artificiale di 54 metri di altezza per 1 chilometro di
circonferenza costruita sui resti di antiche anfore romane, cocci e detriti vari, accumulatisi nei secoli
come residuo dei trasporti che giungevano al porto di Ripa Grande.
Lo stemma presenta un’anfora romana d’oro su sfondo rosso.
Istituito il 9 dicembre del 1921, e situato sulla riva sinistra del Tevere, Testaccio è la vera anima
popolare e verace di Roma: qui, romani e turisti si ritrovano nelle numerose trattorie
caratteristiche per gustare gli ottimi piatti della cucina tradizionale romana o per sorseggiare un
cocktail con gli amici in uno dei tanti locali trendy che animano la movida capitolina.
Dopo il Medioevo, quando l’area cessò la sua funzione di discarica, il Monte Testaccio divenne sede
di manifestazioni popolari, dagli antichi giochi pubblici, come il ludus Testacie (una sorta di
corrida), alle note “ottobrate romane” dell’Ottocento, feste di chiusura della vendemmia.
In seguito, alla base della collinetta, furono scavate delle grotte, adibite a cantine e stalle (i cosiddetti
“grottini”), oggi diventati ristoranti e disco-pub, amati luoghi di ritrovo e convivialità dei giovani romani.
Oltre al già citato Monte dei Cocci, da notare è la Piramide Cestia, l’originale sepoltura del pretore,
tribuno della plebe e membro del Collegio dei Septemviri Epulones Caio Cestio, edificata tra il 18 e il
12 a.C., Ponte Sublicio, il lungo ponte (oltre 100 metri) che unisce Porta Portese con il quartiere
Testaccio, la Chiesa di Santa Maria Liberatrice, la chiesa parrocchiale del Rione dedicata da Papa Pio
X alla memoria della popolazione romana, il Mattatoio, uno dei più importanti edifici di archeologia
industriale della città per la modernità e l’originalità delle sue strutture, oggi luogo consacrato alla
cultura e all’arte contemporanea, l’area archeologica dell’Emporium, l’antico porto fluviale di
Testaccio edificato nel I secolo d.C., che rappresentava uno degli snodi commerciali fondamentali per
l’approvvigionamento di tutta la città: è qui che arrivavano le merci provenienti da tutto il Mediterraneo
che, una volta sbarcate nei porti di Ostia e Porto, erano poi smistate nei mercati cittadini: vino, grano,
garum (salsa di interiora di pesce usata come condimento) e, soprattutto, olio.
“Il cimitero è uno spazio aperto tra le rovine, ammantato d’inverno di violette e margherite. Potrebbe
far innamorare qualcuno della morte, pensare di essere seppelliti in un posto così dolce”: così, Percy
Byssie Shelley descrive il Cimitero Acattolico di Testaccio, un luogo romantico dove arte, bellezza e
natura intessono una trama ricca di suggestioni e di richiami al passato; questo splendido luogo è
tutt’ora in uso dal lontano 1716.
Il cimitero, zona monumentale d’interesse nazionale dal 1918, accoglie circa 4000 sepolture, per lo
più inglesi e tedeschi, ma anche italiani, americani, scandinavi, russi, greci e qualche orientale, di
tutte le confessioni religiose dall’Islam allo Zoroastrismo, dal Buddismo al Confucianesimo.
San Saba
Il XXI Rione è San Saba: detto popolarmente “il Piccolo Aventino”, è di istituzione recente (benché di
antica urbanizzazione), si trova al margine del grande polmone verde e archeologico del complesso
Terme di Caracalla-Circo Massimo-Palatino.
Nello stemma è presente una luna crescente argentata nella parte superiore e l’arco di Diana in
oro nella parte inferiore (allusivo a Diana Aventina, il cui tempio fu edificato al centro dell’Aventino dal
Re Servio Tullio).
Il cuore di San Saba è il giardino di Piazza Bernini.
Il Rione prende il suo nome dalla Basilica di San Saba, edificata sulle pendici del Colle Aventino: nel
VII secolo la chiesa fu dedicata a San Saba, monaco di Cappadocia e capo del monachesimo
orientale, e fu eretta sul luogo in cui sorgeva la casa-oratorio di Santa Silvia, madre di San Gregorio
Magno; rimase patrimonio dei monaci greci fino all’XI secolo quando, dopo lo Scisma d’Oriente, passò
ai frati benedettini.
Tra i monumenti, i luoghi di interesse e gli edifici di culto più rappresentativi del Rione citiamo: le
Terme di Caracalla, uno dei più grandi e meglio conservati complessi termali dell’antichità, edificate
per volere dell’Imperatore Caracalla sul Piccolo Aventino tra il 212 ed il 216 d.C.; la Basilica dei Santi
Nereo e Achilleo, decorata con splendidi affreschi del Pomarancio che, grazie alla sua posizione
invidiabile, è tra le chiese più amate in cui scambiarsi il giuramento d’amore; la Casina del Cardinale
Bessarione, un inconsueto esempio di villa rinascimentale extraurbana in una zona ricca di
testimonianze dell’età repubblicana e imperiale, l’Arco di Druso, un pregevole residuo dell’Acquedotto
Antoniniano che attraversava Via Appia Antica per alimentare le Terme di Caracalla, ed infine Porta
San Paolo che, edificata intorno al III secolo d.C., è tra le più grandiose e meglio conservate tra quelle
incastonate nelle Mura Aureliane.
Prati
E si arriva così al XXII Rione, nonché ultimo Rione di Roma: Prati, il cui stemma rappresenta
il Mausoleo d’Adriano, meglio conosciuto come Castel Sant’Angelo, in argento su sfondo azzurro, che,
pur facendo parte del Rione Borgo, fu scelto forse per la vicinanza dei due Rioni.
È così denominato perché nell’antichità consisteva in vigneti e canneti parte della proprietà di
Domizia, moglie di Domiziano.
Durante il Medioevo la zona prese il nome di Prati di San Pietro, in riferimento all’adiacente Basilica
Vaticana.
Fino al 1883, anno in cui si ebbero i primi interventi di edilizia e di urbanizzazione, la zona era ancora
una distesa di campi coltivati, prati naturali, pascoli e anche di paludi.
Oggi, nel Rione, sorge il Palazzo di Giustizia, imponente edificio dall’architettura neo-barocca, sede
della Corte suprema di Cassazione e del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma: il Palazzo è
anche conosciuto con l’appellativo di “Palazzaccio”, soprannome datogli dai romani proprio per la sua
mole.
Istituito il 21 agosto del 1921, come ultimo Rione della Capitale, il Rione Prati è un elegante quartiere
di Roma che, con le sue boutique raffinate, i ristoranti dalla cucina ricercata e i locali trendy, è uno dei
luoghi di ritrovo più amati dai giovani romani che qui si incontrano per un semplice aperitivo, per una
cena gourmet o per fare acquisti in Via Cola di Rienzo, una delle principali vie dello shopping della
Capitale.
Situato sulla sponda destra del Tevere, a pochi passi dal Vaticano e dalla Basilica di San Pietro, il Rione
deve il suo nome ai prati di Castello che, adiacenti al Mausoleo di Adriano, erano il luogo dove i romani
giungevano in calessino o via fiume per una piacevole scampagnata.
Dopo l’Unità d’Italia e la proclamazione di Roma Capitale, il territorio fu interessato da un’intensa
opera di urbanizzazione messa in atto dalla borghesia torinese giunta in città dalla vecchia capitale.
Gli edifici presenti nel Rione rispecchiano prevalentemente i dettami architettonici del periodo: lo stile
umbertino, di chiara impronta piemontese, con i suoi palazzi massicci e imponenti; il più leggero e
raffinato stile liberty con i suoi preziosi richiami alla leggiadria del mondo naturale e animale.
Tra i luoghi, i musei e gli edifici più importanti del Rione citiamo Piazza Cavour, la grande piazza
dedicata allo statista piemontese Camillo Benso Conte di Cavour, il Museo delle Anime del Purgatorio,
che raccoglie una curiosa collezione di documenti vari e reliquie di misteriose tracce dell’aldilà,
l’annessa Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, detta “del Suffragio” che, costruita in stile neogotico, si è
guadagnata l’appellativo di “Piccolo Duomo di Milano”, la Chiesa Valdese, dalla bella architettura
eclettica che fonde l’austerità dello stile neoromanico alla leggerezza del liberty.
Termina qui la nostra storia sui Rioni di Roma, sperando di aver trasmesso, ancora una volta, la voglia
di andare a “curiosare” tra tutto quello che, nel passato e nel presente, la nostra bella città ci offre.
(fine)
__
foto: Parco archeologico del Celio
Dicembre 2024 © Maria Teresa Protto

Fondazione Premio Antonio Biondi
Via Garibaldi 34
03017 Morolo (FR)
Fondazione terzo settore
C.F. 92088700601
segreteria@
IBAN:
IT18I0529714801CC1030072196
BIC: BPFRIT3FXXX
editoriale in collaborazione con
Centro studi su innovazione,
comunicazione ed etica.