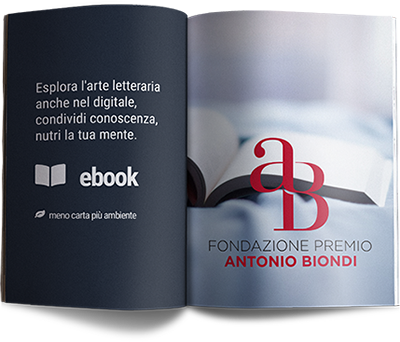EDITORIALE DELLA FONDAZIONE
I Rioni di Roma (terza parte)
Le 22 regiones di Roma
Sant’Angelo
Con Sant’Angelo arriviamo al nostro terzo appuntamento con i Rioni di Roma: l’XI è il più piccolo tra i
Rioni romani e si trova sulla sponda sinistra del Tevere davanti all’Isola Tiberina e la sua importanza
storica deriva soprattutto dalla presenza del Ghetto e della Sinagoga.
Lo stemma rappresenta ovviamente un angelo con un ramo di palma nella mano sinistra.
In un’altra versione, l’angelo brandisce una spada nella mano destra ed una bilancia nella sinistra, ma
conosciamo anche la versione in cui sullo stemma appare un pesce, poiché fra le rovine del Portico
d’Ottavia vi era, fino alla sua demolizione a fine Ottocento, il Foro Piscario (mercato del pesce).
E proprio qui, sotto le colonne del Portico d’Ottavia, costruzione monumentale dedicata
dall’Imperatore Augusto alla sorella e l’unico conservato dei grandi portici romani, sorgeva la Chiesa di
Sant’Angelo in Pescheria, prima nota come Sant’Agnolo Pescivendolo: da qui il nome del Rione.
Sul muro vicino al Portico è ancora oggi visibile la copia di una lastra marmorea (l’originale può essere
visto nei Musei Capitolini) la cui lunghezza dà la dimensione massima dei pesci che potevano essere
venduti interi.
Ma oltre il Tempio Maggiore (cioè la grande e bellissima Sinagoga con il suo originale stile Assiro-
Babilonese), possiamo vedere il Teatro di Marcello (11 a.C.) che probabilmente servì da modello per la
costruzione del Colosseo e fu il primo teatro di Roma dedicato alla poesia e alla musica, la Crypta
Balbi, vasto complesso di edifici antichissimi e una delle sedi del Museo Nazionale Romano e il già
citato Portico di Ottavia.
Infine, ricordiamo la Fontana delle Tartarughe, di cui abbiamo precedentemente raccontato la
leggenda romantica del duca Mattei, il cui palazzo si affaccia sulla piazza dove sorge la fontana, che,
per stupire il futuro suocero che era contrario a dargli in moglie sua figlia, la fece realizzare in una sola
notte.
In Via del Portico di Ottavia, ai numeri civici 1 e 2, c’è la Casa di Lorenzo Manilio, un edificio
molto particolare: costruita nel 1468, l’abitazione attesta la passione del suo proprietario per le cose
romane.
Basti vedere il fascione in marmo che decora la facciata: il proprietario fece incidere a grandi lettere
un testo in latino che tradotto sarebbe: “Mentre Roma rinasce all’antico splendore, Lorenzo Manilio, in
segno di amore verso la sua città, costruì dalle fondamenta sulla piazza giudea, in proporzione con le
sue modeste possibilità, questa casa che dal suo cognome prende l’appellativo di Manliana, per sé e
per i suoi discendenti, nell’anno 2221 dalla fondazione di Roma, all’età di 50 anni, 3 mesi e 2 giorni;
fondò la casa il giorno undicesimo prima delle calende di agosto”.
Inoltre, sugli architravi il nome Lorenzo Manili si ripete per tre volte in latino e una in greco, sulle
finestre è inciso il motto “Ave Roma” e il basamento del palazzo è costellato da reperti
archeologici incastonati nell’intonaco.
Il Rione è molto amato dai romani e dai turisti che si riuniscono qui per gustare le ricette della
rinomata cucina tradizionale ebraico-romanesca in uno dei ristoranti della zona, oppure un’ottima
torta di visciole e ricotta nella famosa pasticceria Boccione o, infine, un appetitoso trancio di pizza
nell’antico forno Urbani.
Ripa
Il XII Rione è Ripa: lo stemma è una ruota bianca su sfondo rosso che ricorda lo scalo fluviale presente
nel Rione, a cui appartiene anche l’Isola Tiberina che insieme all’Aventino e alla Valle Murcia formano
il Rione.
Nel 1921 con delibera comunale furono “staccati” dall’antico corpo topografico i Rioni di Testaccio e
San Saba; il suo nome deriva da Ripa Grande, il porto fluviale più grande di Roma a cui approdavano le
merci che transitavano sul Tevere da e verso Portus (Porto, l’attuale Fiumicino).
Al Rione appartengono siti archeologici come il Circo Massimo, il più grande edificio per lo spettacolo
dell’antichità e uno dei più grandi di tutti i tempi (600 metri di lunghezza per 140 metri di larghezza), e
la Cloaca Maxima che, realizzata tra il 534 e il 509 a.C. da Tarquinio il Superbo, forse non sarà la più
antica, ma sicuramente è la più grande (maxima) condotta fognaria dell’antichità ancora oggi
funzionante.
La storia del Circo Massimo è strettamente legata alle origini di Roma: secondo la leggenda, al suo
interno ebbe luogo una delle vicende più significative per la sopravvivenza della città e dei suoi antichi
abitanti: nella Valle Murcia, su cui sorse il Circo, ebbe luogo il Ratto delle Sabine.
Romolo, il fondatore di Roma, si rivolse alle popolazioni circostanti per procurarsi delle donne in età
fertile affinché i suoi sudditi potessero procreare per popolare la nuova città, ma i vicini ebbero l’ardire
di rifiutare, motivo per cui Romolo organizzò un magnifico spettacolo per attirare tutti gli uomini e
rapire le donne.
Inoltre, possiamo vedere, la Basilica di Santa Maria in Cosmedin, sotto il cui portico si trova la famosa
Bocca della Verità, l’antichissimo tombino dal volto umano legato ad una leggenda un po’ macabra
per la credenza che la bocca potesse mordere la mano di chi non avesse affermato il vero; la Villa
Magistrale del Sovrano Ordine di Malta sull’Aventino, famosa soprattutto perché dal buco della
serratura del grande portone d’ingresso si gode di una vista mozzafiato della cupola della Basilica di
San Pietro incorniciata dalle siepi dello splendido giardino; l’Isola Tiberina, l’unica isola urbana del
Tevere, il cui profilo ricorda una nave; il Roseto Comunale che, situato tra il Circo Massimo e il Colle
Aventino, accoglie circa 1.100 specie di rose provenienti da tutto il mondo; il romantico Giardino degli
Aranci il cui Belvedere che affaccia sul Tevere offre uno splendido panorama di Roma.
Sull’Isola Tiberina, invece, dove anticamente si celebrava il culto del Dio della Medicina Esculapio, si
trovava un tempio a lui dedicato; qui sorse la Chiesa di San Bartolomeo all’Isola che, oltre a svolgere
funzioni liturgiche, come un vero e proprio ospedale accoglieva i malati e li curava con l’acqua,
ritenuta miracolosa, raccolta dal pozzo al suo interno; solo dopo molto tempo, però, si scoprì che
quell’acqua non aveva nulla di miracoloso e che anzi era fetida e non curava i pazienti, ma li uccideva.
Il pozzo fu definitivamente sbarrato e si può vedere ancora oggi.
Al Velabro, nelle acque stagnanti di un porticciolo naturale, sembra approdò Evandro, capo della
colonia degli Arcadi, per formare sul Palatino il nucleo del suo piccolo regno.
E fu proprio lì, continua la leggenda, che la piccola cesta con Romolo e Remo fu trovata e presa in
custodia dalla lupa.
Secondo la tradizione, dall’Aventino Remo avrebbe osservato il volo dei sei avvoltoi che
preannunciavano la sua sconfitta nella contesa con il gemello Romolo: Plutarco fa derivare da questo
episodio il nome del Colle Aventino (“ab avibus”), che in precedenza si chiamava “Mons Murcius”, dai
mirti che lo ricoprivano.
Altri storici riferiscono invece che il nome Aventinus deriva dal mitico Re di Alba che sarebbe stato
colpito mortalmente da un fulmine sul Colle e qui sarebbe stato sepolto.
Nel 456 a.C., con una legge Icilia, l’intera collina dell’Aventino fu dichiarata di proprietà pubblica e
distribuita ai plebei perché vi costruissero case: da allora si andò formando un quartiere fittamente
popolato al punto che, nell’età di Augusto, non rimaneva spazio per edifici pubblici.
Solo in età imperiale l’Aventino perse le sue caratteristiche di quartiere popolare e commerciale per
trasformarsi in un quartiere aristocratico: il Colle venne incluso nelle 14 regiones e con l’Imperatore
Claudio venne incluso nei limiti del pomerio.
I Servili, i Sura, i Decii (che costruirono le Terme Deciane) furono i patrizi abitatori
dell’Aventino insieme a quell’Asinio Pollione famoso generale nonché scrittore e poeta.
Quando nel IV secolo il cristianesimo splendeva in episodi di mistica bellezza, ci fu il massimo
splendore per questa zona: ai templi pagani subentrarono luoghi di culto cristiano e chiese.
Il Piano Regolatore Viviani del 1883 avrebbe voluto trasformare l’Aventino in un quartiere per
abitazioni, con palazzoni e strade a scacchiere, ma per fortuna il piano non fu mai attuato fino a
quando, nel 1914, si iniziò quel lento e garbato inurbamento a villini che caratterizza tutt’oggi una
tipologia edilizia rispettosa dell’ambiente.
Trastevere
Trastevere, XIII Rione, deriva dal latino trans Tiberim (al di là del Tevere), poiché il centro della Città si
sviluppava sull’altra sponda e soltanto dalla fine dell’età repubblicana Trastevere si andò coprendo di
edifici utilitari e di case d’abitazione, quest’ultime destinate ai lavoratori ed ai piccoli commercianti,
attirati dall’attività economica del fiume e delle vicine installazioni.
Lo stemma presenta una testa di leone d’oro in campo rosso, poiché – secondo una storia “ufficiosa” –
ai piedi del Campidoglio veniva tenuto in gabbia un leone, sostituito nel 1471 dalla Lupa Capitolina.
Il Rione, il più esteso di Roma, è oggi uno dei luoghi della movida capitolina notturna, ma di giorno
conserva ancora quella magia della Roma papalina con i suoi vicoli tortuosi, con le botteghe di
artigiani e le osterie.
Già in età imperiale il Rione si trasformò in un immenso quartiere: l’abitavano vasai, operai delle
manifatture del cuoio (“coriaria”), dell’avorio, ebanisti, mugnai dei molini ad acqua
sul Tevere (“molinae”), facchini degli infiniti magazzini e depositi, fornaciai delle fabbriche di laterizi
dei Monti Vaticani, attive fino a pochi anni fa (in via delle Fornaci e Valle dell’Inferno).
La viabilità della riva destra del Tevere era basata su due strade assai antiche, in origine extraurbane,
che si dirigevano al ponte primitivo, il Sublicio: lo sbocco del ponte si trovava immediatamente a valle
di quello del più tardo “Ponte Emilio”.
A partire da questo punto divergevano la “Via Campana” verso sud e la “Via Aurelia” verso ovest: la
prima si dirigeva verso le saline alle foci del Tevere e costituì più tardi il primo tratto della “Via
Portuensis”, mentre la seconda, assai meglio riconoscibile, aperta nel III secolo a.C., corrisponde
esattamente al tracciato attuale di Via della Lungaretta che si può seguire fino a Piazza Santa Maria in
Trastevere, per poi salire sul Gianicolo ed uscire dalla Porta Aurelia.
Il Rione conservò nei secoli le caratteristiche delle origini, cioè un aspetto ed un carattere di povertà e
di provvisorietà che lo distinguevano dal resto della città e su cui si basavano anche le costruzioni e la
struttura viaria: un ammasso disordinato di case e casupole distribuite in un groviglio di vie e viuzze
orientate sul Tevere e nel mezzo le primitive Chiese di Santa Maria in Trastevere, probabilmente il
primo luogo ufficiale di culto cristiano a Roma, e di San Crisogono, che svettavano su tutte le altre
costruzioni.
Il Rione si trasformò agli inizi del Cinquecento con l’apertura, per volere di Giulio II, di due grandi assi
viari: uno corrispondente alle attuali Via della Lungara-Via della Scala e l’altro a Via della Lungaretta, in
pratica un rettilineo che collegava il Vaticano da Porta di Santo Spirito fino al cuore della città, il
Campidoglio ed il Palatino.
Santa Maria in Trastevere, su cui convergevano le due strade, divenne il cuore del Rione e questo
carattere si accentuò ulteriormente un secolo dopo, quando Paolo V aprì un terzo asse viario per
congiungere questa chiesa con quella di San Francesco a Ripa (attuale Via di San Francesco a Ripa).
Queste vie furono aperte in un Rione popolare e mantennero intatto questo carattere anche nei secoli
successivi: non vi risiedettero cardinali, non vi sorsero chiese sontuose né furono creati palazzi della
grande aristocrazia papalina ma di una più modesta nobiltà cittadina.
Per due secoli e mezzo Trastevere si sviluppò sulla base di questa struttura urbanistica: dalla pianta di
Roma di G. B. Nolli del 1748 appariva evidente, infatti, che il Rione aveva maturato, sulla tripartizione
viaria, un equilibrio, un’unità, un’armonia nel disporsi che saranno sconvolti soltanto dopo il 1870,
allorché si diede il via ad un nuovo assetto urbanistico.
L’insufficienza finanziaria e le lungaggini burocratiche evitarono, fortunatamente, che la cultura
cisalpina di quei decenni distruggesse del tutto la zona.
L’intervento più importante fu, nel 1886, l’apertura del Viale del Re, poi Viale del Lavoro ed infine Viale
Trastevere, per congiungere, attraverso un nuovo ponte (ossia Ponte Garibaldi, aperto due anni
dopo), Via Arenula con la stazione ferroviaria che si affacciava su Piazza Ippolito Nievo (un particolare
della costruzione è un bellissimo orologio), che doveva essere il terminale dei collegamenti con il nord
lungo il Tirreno.
Ma il viale non fece in tempo ad essere ultimato che la stazione era già stata declassata, per il traffico
passeggeri, a favore di Roma Termini: rimase adibita allo smistamento merci fino agli anni Trenta
allorché perse anche questa funzione, divenendo per parecchi anni la sede dell’Istituto Sperimentale
delle FS, mentre la Stazione di Roma Trastevere, ora funzionante, si trova alla fine del viale.
Pur se risparmiato dai più ambiziosi progetti che colpirono pesantemente altri Rioni della città,
Trastevere uscì stravolto dalla costruzione di questo viale, che da solo alterò l’intero orientamento
della zona e la divise in due parti che non si sarebbero mai più saldate: le due vie sopra
menzionate della Lungaretta e di San Francesco a Ripa persero, con l’unità e la continuità, anche la
funzionalità per cui erano state concepite.
A Trastevere possiamo vedere: Palazzo Corsini alla Lungara, che insieme a Palazzo
Barberini costituisce il Museo Nazionale di Arte Antica in cui si trova l’Orto Botanico di Roma; Villa
Farnesina, una delle più riuscite e armoniose creazioni del Rinascimento italiano in cui si possono
ammirare gli affreschi opera di Raffaello Sanzio e della sua scuola; la Basilica di Santa Cecilia; il
Santuario di San Francesco a Ripa Grande, con la straordinaria statua giacente che raffigura l’Estasi
della Beata Ludovica Albertoni opera del Bernini; il Museo di Roma in Trastevere, che ospita vari
materiali che testimoniano la storia della vita quotidiana e delle tradizioni romane; la Fontana-
Monumento di Giuseppe Gioacchino Belli, realizzata grazie ad una sottoscrizione popolare in onore
del grande poeta romanesco; la Fontana dell’Acqua Paola sul Colle del Gianicolo, il magico
“Fontanone” tanto amato dai romani; il Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina,
che ripercorre la storia, i luoghi ed i personaggi del Risorgimento tra cui Giuseppe Garibaldi, la sua
compagna Anita e Goffredo Mameli, che in questa zona di Roma hanno combattuto contro l’esercito
francese.
Sul Gianicolo, proprio vicino alla statua di Garibaldi, si può ammirare un panorama sia del centro
storico sia della cupola di San Pietro e sotto il Belvedere, dal 1904, alle ore 12 in punto di ogni giorno
tre soldati sparano un colpo di cannone a salve.
La tradizione risale a Pio IX che il 1° dicembre 1847 introdusse questo servizio alla cittadinanza per
avere un segnale unico dell’ora ufficiale, visto che le chiese cittadine suonavano le campane in orari
diversi.
Borgo
Lo stemma del XIV Rione rappresenta un leone accovacciato con di fronte tre monti sovrastati da una
stella (dal nome Città Leonina, con cui il Rione viene anche chiamato).
Questi ultimi, insieme al leone rampante, fanno parte dell’insegna di Papa Sisto V che elevò Borgo a
quattordicesimo Rione di Roma; in altre versioni, i tre monti sono poggiati su un forziere che
rappresenterebbe il tesoro e gli archivi segreti del Vaticano, poi trasferiti da Sisto V a Castel
Sant’Angelo, che appunto, nello stemma, sono sorvegliati dal leone.
Nonostante sia stato fortemente trasformato durante la prima metà del XX secolo, Borgo mantiene
ancora oggi il suo ruolo di “ingresso” alla Basilica di San Pietro e ai Musei Vaticani.
Il suo territorio è disseminato di ristoranti, hotel, piccoli negozi di souvenir religiosi e storiche botteghe
di abiti e paramenti talari.
Il suo nome deriva dalla parola sassone Burg, che designa una sorta di piccolo fortilizio o un villaggio
di piccole dimensioni racchiuso in una cinta muraria e separato dalla città: molte delle sue strade non
sono chiamate vie ma borghi.
Tra i monumenti e i luoghi di maggiore interesse storico e turistico troviamo Castel Sant’Angelo,
l’antico mausoleo fortificato che custodiva le spoglie dell’Imperatore Adriano e che oggi è la sede
del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, Ponte Sant’Angelo, forse il più bel ponte di Roma, su cui
sono collocate due schiere di magnifici angeli che scortano coloro che lo attraversano sulla riva
opposta del Tevere verso San Pietro, il Passetto di Borgo, detto “er Coridore de Borgo”, il passaggio
merlato e sopraelevato che unisce i Palazzi Vaticani a Castel Sant’Angelo, veloce via di fuga e di
salvezza dei Papi minacciati dalle invasioni delle popolazioni germaniche, il Complesso Monumentale
di Santo Spirito in Sassia, che, edificato intorno al 727 d.C. sull’area che anticamente era occupata
dagli Horti di Agrippina Maior (14 a.C.-33 d.C.) e di cui ancora conserva, nei sotterranei, resti di pareti
di opus reticulatum, pavimenti a mosaico, sculture e affreschi e che ospitava i pellegrini diretti alla
Tomba dell’Apostolo Pietro.
Poco distante, inoltre, sorgeva un’altra delle piramidi che, dopo la conquista dell’Egitto nel 31 a.C. da
parte di Ottaviano Augusto, in seguito alla morte di Cleopatra, l’edilizia funeraria romana cominciò a
edificare ispirandosi ai modelli egiziani, dando vita ad una vera e propria moda.
La piramide, indicata come Meta Romuli, “Piramide vaticana” o “Piramide di Borgo”, si credeva fosse il
luogo di sepoltura di Remo, mentre la Piramide Cestia, vicino Porta San Paolo, si pensava essere la
tomba del fratello Romolo, il fondatore di Roma.
A Borgo Pio, all’angolo con Via del Campanile, potete scorgere un’incisione piuttosto curiosa dallo
scopo non immediatamente comprensibile, ma di grande importanza per chi viveva in quest’area:
un cerchio scolpito nella pietra.
Di cosa si tratta?
Nei periodi di carestia, i numerosi fornai presenti nella zona risparmiavano sulla quantità di farina
usata per le pagnotte facendone sempre di più piccole, nonostante il prezzo rimanesse invariato; la
cosa non passò inosservata e fu così che venne creato quel disco che stava a rappresentare la misura
esatta entro la quale dovevano rientrare le pagnotte per essere vendute e per non frodare la
popolazione affamata.
Come già raccontato, negli anni ‘30, per permettere l’edificazione dell’attuale Via della Conciliazione,
che collegava idealmente lo Stato Vaticano con lo Stato italiano, venne demolita la cosiddetta Spina di
Borgo, così chiamata perché i suoi edifici erano racchiusi tra due strade convergenti, Borgo Nuovo e
Borgo Vecchio, che davano all’isolato la forma di un triangolo che puntava a Castel Sant’Angelo.
Costituita da un intrico di vicoli su cui sorgevano abitazioni modeste insieme a palazzi nobiliari, molti
dei quali smontati e ricostruiti ai lati di via della Conciliazione, la Spina di Borgo aveva
una particolarità, oggi, purtroppo, perduta: una volta usciti dal dedalo di stradine o girato l’angolo di un
palazzo, come per magia si palesava agli occhi dei visitatori la magnificenza del Colonnato del
Bernini e della Basilica di San Pietro.
(fine terza parte)
Dicembre 2024 © Maria Teresa Protto

Fondazione Premio Antonio Biondi
Via Garibaldi 34
03017 Morolo (FR)
Fondazione terzo settore
C.F. 92088700601
segreteria@
IBAN:
IT18I0529714801CC1030072196
BIC: BPFRIT3FXXX
editoriale in collaborazione con
Centro studi su innovazione,
comunicazione ed etica.